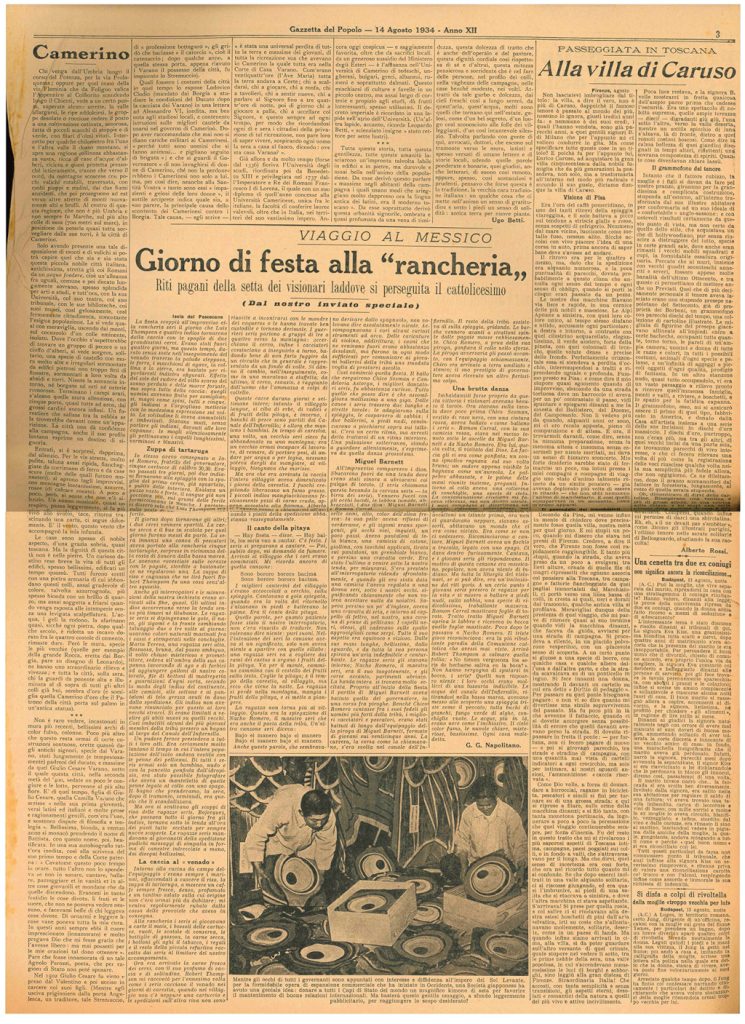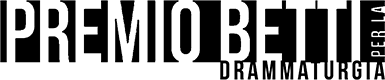Dalla Gazzetta del popolo – 14 agosto 1934
Ripreso da
L’Appennino camerte, anno XIV – Numero 34 – Camerino, 25 agosto 1934 – XII
Camerino
Chi venga dall’Umbria lungo il corso del Potenza, per la via Prolaquense; oppure per quel ramo della via Flaminia che da Foligno valica l’Appennino al Colfiorito scendendo lungo il Chienti, vede a un certo punto, superate alcune strette, la valle allargarsi, le ripe addolcirsi, le groppe desolate o rocciose cedere il posto a una coltivazione ostinata, amorosa, fatta di piccoli scacchi di stoppie e di verde, con filari d’olmi vitati. Interrotto per qualche chilometro fra l’una e l’altra valle il dosso montano, si apre una regione collinosa abbastanza vasta, ricca di case d’acque d’alberi, ricinta e quasi protetta pressoché intieramente, tranne che verso il nord, da montagne scoscese con pochi valichi rotabili, traversata, con moli pioppi e mulini, dai due fiumi anzidetti, che poi proseguono ad est verso altre strette di monti nuovamente alti e brulli. Al centro di questa regione, che non è più Umbria e non sempre fu Marche, sul più alto colle di essa (700 metri sul mare), in posizione da poterla quasi tutta sorvegliare dalle sue torri, è la città di Camerino.
Solo avendo presente una tale disposizione di monti e di valichi si potrà capire quel che sia e sia stata questa piccola nobile città italiana, antichissima, stretta già coi Romani da un aequo foedere, cioè un’alleanza fra uguali, comune e poi ducato lungamente sovrano, spesso splendida per arti e studi, e tuttora, con la sua Università, col suo teatro, col suo tribunale, con le sue biblioteche, coi suoi musei, così gelosamente, così fermamente cittadinesca, nonostante l’esigua popolazione. La si vede quasi con meraviglia, uscendo dai monti, sul cocuzzolo d’un colle eminente, isolato. Dove l’occhio s’aspetterebbe di trovare un gruppo di pecore o un ciuffo d’alberi, si vede sorgere, solitario, una specie di castello con mura molto alte e irregolari sormontate da edifici pietrosi non troppo fitti di finestre, sormontati a loro volta da absidi e torri. Niente la annuncia intorno, né borgate né orti né osterie rumorose. Terminano i campi arati, s’alzano quelle mura silenziose, con cinque porte, quasi tutte ad arco, dai grossi cardini ancora infissi. Un forestiere che salisse tra la nebbia se la troverebbe davanti come un’apparizione. La città non dà confidenze alla campagna, anche il suo profilo lontano esprime un destino di signoria.
Entrati, si è sorpresi, dapprima, dal silenzio. Per le vie strette, molto pulite, taluna assai ripida, fiancheggiate da corrimano di ferro e da case scure (molte delle quali furono monasteri), si aprono tagli improvvisi, con montagne lontanissime, azzurre, rosee (di calcare rosato). A poco a poco, però, si sente che non v’è silenzio. Un suono musicale, quasi un respiro, passa leggermente, si fa più vivo allo svolto, tace, ritorna trascinando una carta, ci segue dolcemente. E’ il vento, questo vento che accompagnò la mia infanzia.
Le case sono spesso di nobile aspetto, d’una grazia sobria, quasi toscana. Ma la dignità di questa città non è nelle pietre. Un curioso destino rese breve la vita di tutti gli edifici, spesso bellissimi, edificati un tempo quassù. Tutti furono eretti con una pietra arenaria di cui abbondano questi colli, assai gradevole di colore, talvolta azzurrognola, più spesso bionda con un brillio di quarzo, ma assai soggetta a friarsi quando venga esposta alle intemperie senza una levigata scalpellatura. L’acqua, i geli la rodono, la sfarinano quasi, sicché ogni pietra, dopo qualche secolo, è ridotta un incavo dorato fra le quattro costole di cemento, rimaste dure. Però le mura, specie le più vecchie (quelle per esempio della grande Rocca, eretta dai Borgia, pare su disegno di Leonardo), ne danno uno straordinario rilievo e vivezza; e tutta la città, sulla sera, chi la guardi da ponente alta e illuminata al di sopra di tutti gli altri colli già bui, sembra d’oro (e somiglia quella Camerino d’oro che il Patrono della città porta sul palmo in un’antica statua).
Non è raro vedere, incastonati in mura più recenti, bellissimi archi in color fulvo, colonne. Poco più altro che questo resta ormai di certe costruzioni sontuose, erette quassù dagli antichi signori, specie dai Varano, stati lungamente (e tempestosamente) padroni del ducato, e massime da quel Giulio Cesare Varano, sotto il quale questa città, nella seconda metà del ‘400, sedate un poco le congiure e le lotte, pervenne al più alto fiore. E’ di quel tempo, figlia di Giulio Cesare, quella Camilla Varano che scrisse “nella sua prima gioventù, versi latini ed italiani e molte prose e ragionamenti gentili, com’era l’uso, e sostenea dispute di filosofia e di teologia”. Bellissima, bionda, a ventun anno si monacò prendendo il nome di Battista, con questo nome, poi, beatificata. In una sua autobiografia tutt’ora inedita, così ella scriveva del suo primo tempo e della Corte paterna: “Cavatome questo poco tempo in orare, tutto l’altro non lo spendeva se non in sonare, cantare, ballare, pazzeggiare et in vanità et in altre cose giovanili et mondane che da quelle discendono. Eranomi in tanto fastidio le cose divote, li frati et le suore, che non ne posseva vedere nessuno, e facevami beffe di chi leggeva cose divote. Di ornarmi e leggere le cose vane poneva tutta la mia cura. In questi anni sempre ebbi il cuore imprescionato (innamorato) e molto pregava Dio che mi fosse gratia che l’avesse libero: ma mai possetti per le mie orazioni tal dono ottenere”. Pare che fosse innamorata di un tale Agnolo Perozzi, poeta, che per ragioni di Stato non poté sposare.
Nel 1502 Giulio Cesare fu vinto e preso dal Valentino e poi ucciso in carcere coi suoi figli. (Mentre egli usciva prigioniero dalla porta Angelesca, un traditore, tale Stremuccio, di “professione bottegaro”, gli gridò che baciasse il “catorcio”, cioè il catenaccio; dopo qualche anno, a quella stessa porta, appena riavuto i Varano il possesso della città, fu impiccato lo Stremuccio).
Quali fossero i costumi della città in quel tempo lo espone Lodovico Clodio (mandato dai Borgia a studiare le condizioni del Ducato dopo la cacciata dei Varano) in una lettera ad Alessandro VI, inedita, ma ben nota agli studiosi locali, e contenente istruzioni sulle migliori cautele da usarsi nel governo di Camerino. Dopo aver raccomandato che mai non si diano cariche militari ai Camerinesi, “perché tutti sono uomini che si fanno animosi… e pigliano seguito di brigata”; e che si guardi il Governatore “di non invaghirsi di donne di Camerino, ché non la perdonerebbero i Camerinesi non solo a lui, ma, per così dire, neanche alla Santità Vostra” tanto sono essi “impazienti e gelosi delle loro donne”, il sottile arciprete indica quale sia, a suo parere, la principale causa dello scontento dei Camerinesi contro i Borgia. Tale causa – egli scrive – “è stata una universal perdita di tutta la terra e massime dei giovani, di tutta la ricreazione sua che avevano in Camerino la quale tutta era nella Corte di Casa Varano. Com’erano ventiquattr’ore (l’Ave Maria) tutta la terra andava a Corte; chi a scaldarsi, chi a giocare, chi a ronfa, chi a tavolieri, chi a sentir nuove, chi a sentir nuove, chi a parlare al Signore fino a tre quattr’ore di notte, poi di giorno chi a giocare a palla, chi a uccellare col Signore, e questo sempre ad ogni tempo, per modo che ricordandosi ogni di e sera i cittadini della privazione di tal ricreazione, non pare loro di saper vivere, sospirando ogni uomo la sera a casa al fuoco dicendo: ove sta casa Varana?”
Già allora e da molto tempo (forse dal 1336) fioriva l’Università degli studi, riordinata poi da Benedetto XIII e privilegiata nel 1737 dall’Imperatore e Re dei Romani Francesco I di Lorena, il quale con un suo diploma di quell’anno concesse alla Università Camerinese, unica fra le italiane, la facoltà di conferire lauree valevoli, oltre che in Italia, nei territori del suo vastissimo impero. Ancora oggi cospicua – e saggiamente favorita oltre che da sacrifici locali da un generoso sussidio del Ministero degli Esteri – è l’affluenza nell’Università di Camerino di tedeschi, ungheresi, bulgari, greci, albanesi, rumeni e soprattutto dalmati. Questo mischiarsi di culture e favelle in un piccolo centro, ma assai largo di cortesie e propizio agli studi, dà frutti interessanti, spesso utilissimi. Il decreto imperiale è ricordato in una lapide nell’atrio dell’Università (Un’altra lapide, accanto, ricorda Leopardo Betti, “scienziato insigne” stato rettore per sette lustri).
Tutta questa storia, tutta questa gentilezza, tutte queste umanità lasciarono un’impronta talvolta labile in edifici e in pietre, ma durevole e assai bella nell’animo della popolazione. Da esse derivò questo parlare “massime negli abitanti della campagna i quali usano modi che arieggiano molto dappresso ora la lingua antica dei latini, ora il moderno toscano”. Da esse soprattutto derivò questa urbanità signorile, ombrata e quasi profumata da una vena di timidezza, questa dolcezza di tratto che è anche dell’operaio e del pastore, questa dignità cordiale così rispettosa di sé e d’altrui, questa mitezza pensierosa e sorridente che è nel fare delle persone, nel profilo dei colli, nella vaghezza delle campagne, nelle case benché modeste, nei volti. Attratti da tale garbo e dolcezza, dai cieli freschi così a lungo sereni, da quest’aria, quest’acqua, molti sono quelli che tornano qui nell’estate, gelosi, come d’un bel segreto, d’uno luogo così sconosciuto alle folle dei villeggianti, d’un così incantevole silenzio. Talvolta parlando con gente di qui, avvocati, dottori, che escono sul tramonto verso le mura, intinti e spesso versati di umane lettere e di storie locali, udendo quelle parole ponderate e bonarie, quei giudizi, anche letterari, di suono così remoto, eppure, spesso, così sostanziosi e prudenti, pensavo che forse questa è la tradizione, la vecchia cara tradizione italiana: un qualche cosa che ci mette nell’animo un senso di gratitudine e sotto i piedi un senso di solidità: antica terra per nuove piante.
Ugo Betti